N° 2
I QUADERNI DI MATERIAS
La ricerca tra innovazione e rischi.
Il ruolo dello Stato e quello dell’Industria.
Lo scouting di giovani talenti e l’importanza del team.
A colloquio con Annamaria Colao
12 - 2020
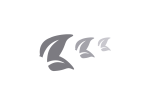
di Luigi Nicolais, presidente di Materias
Apprendere, cercare, inventare: tra queste azioni, che svolgiamo nel quotidiano, c’è quella dell’innovare, una costante applicazione della ricerca per trasformare la nostra società al meglio e in meglio. Questa trasformazione nasce dall’audacia scientifica che trova la sua estensione nel coraggio di affrontare un’impresa imprenditoriale. Questa continuità si deve esprimere soprattutto nel cuore delle università, attraverso i giovani, sotto forma di un rapporto di fiducia e di scambio tra formazione, ricerca e impresa. Questa è la sfida di oggi. Non si può ridurre l’innovazione a un’invenzione che incontra il mercato. Dietro le quinte di un’idea che si trasforma in prodotto ci sono le nostre start up che emergono, le PMI che sviluppano i brevetti. E questo fa dell’innovazione l’energia vitale dell’economia più avvincente.
Siamo nel secolo dell’iper-innovazione che scandisce con un ritmo senza precedenti la nostra società caratterizzata da rapidi, numerosi e inevitabili cambiamenti. In un mondo in cui tutto sta accelerando, se vogliamo mantenere il controllo del nostro futuro e costruirlo piuttosto che subirlo, rafforzare il nostro modello di innovazione è un imperativo categorico. Tuttavia, una delle peculiarità dell’innovazione è che non risponde a nessun ordine, a nessun processo prestabilito. L’innovazione vive di libertà, apertura, tentativi e fallimenti. Vive di movimento, sperimentazione e pericoli.
Si tratta di una mera risultante del caso? Ovviamente no. Perché l’imprevisto viene provocato, coltivato e accolto. Ed è questo stato d’animo che vorrei trasferire ai giovani innovatori delle università, ed è questa dinamica che li trasformerà nei game changer del domani. Servono per questo maggiori investimenti in ricerca e innovazione, strumenti finanziari specifici per le giovani start up e collaborazioni sempre più efficaci tra pubblico e privato. Un ecosistema nazionale dell’innovazione capace di fronteggiare il fenomeno dello human capital flight, cioè dei cosiddetti “cervelli in fuga”.
Con la seconda uscita dei “Quaderni di Materias” ne abbiamo parlato con la Professoressa Anna Maria Colao, scienziata che ha contribuito con creatività e capacità organizzative a far crescere la ricerca italiana, fornendo un importante supporto a obiettivi sociali di primaria grandezza.
Il nostro Paese ha un grande debito di riconoscenza nei confronti del genio femminile, di donne competenti e coraggiose che hanno lasciato un’impronta nella storia e che lottano quotidianamente per rompere il “soffitto di cristallo” che le sovrasta. Penso a donne come le nostre scienziate italiane che stanno ottenendo grandi risultati in ambito di ricerca nella battaglia al Coronavirus, dimostrando il loro impegno nei confronti della collettività.
Tutto questo rappresenta per il nostro Paese un bene comune da non dissipare. Una via da percorrere, come scriveva Altiero Spineli, che non sarà né facile né sicura, ma che deve essere percorsa e lo sarà.
Le innovazioni deep-tech sono oggi chiamate a fornire soluzioni tecnologicamente avanzate, basate su sfide ingegneristiche e scientifiche dirompenti. Altrimenti definite disruptive innovation, tali intuizioni hanno fra i loro obiettivi l’ambizione di rivoluzionare i mercati esistenti o, in alcuni casi, di crearne di nuovi. Nuovi mercati che ancora non esistono e in grado, repentinamente, di sostituire prodotti, aziende e reti di valore consolidate. I rischi d’impresa per chi si avvicina a questo settore sono dunque alti. Gli investitori di venture capital sono cauti. Le tecnologie di cui parliamo richiedono solitamente capitali elevati, tempi lunghi e rendimenti incerti rispetto alle già collaudate tecnologie digitali, che - al contrario - possono basare la loro crescita su innovazioni di tipo incrementale. In questi casi, il finanziamento pubblico diventa essenziale per attraversare la cosiddetta “Valle della Morte”, quel lembo di terra che separa l’idea dal mercato e dove purtroppo perdono la vita molteplici intuizioni scientifiche ad alto contenuto di conoscenza, che senza l’adeguato sostegno economico di un investitore muoiono sul nascere.
Professoressa Colao, c’è bisogno dunque dello Stato? Di più Stato? Si avverte ancora la necessità, in sostanza, di sovvenzioni tradizionali e progetti da parte delle istituzioni pubbliche per sostenere la ricerca? Iniziative su cui si potrà chiedere, in un secondo momento, alla finanza privata di co-investire...
“In realtà, questo è un grave errore, a mio avviso, che ha commesso lo Stato italiano. Quello di investire tantissimo soltanto nella ricerca industriale e nella ricerca applicata. Quasi a dire “io non voglio il rischio che qualcosa sia un libero pensiero”. E questo è sbagliato. Perché alla fine ciò che conta è che sia anche lo Stato a fare la sua parte e fornire un sostegno concreto ai giovani ricercatori. Ai liberi pensatori. Altrimenti noi avremo sempre e solo una ricerca che deve portare immediatamente ad un risultato. Il che sarebbe una grossa limitazione. Il pensiero originale deve avere comunque qualcuno che lo finanzi e soltanto lo Stato può farlo. Non penso che si debba arrivare, ad esempio, ad un prototipo per ottenere un finanziamento. Perché chissà quanti prototipi ci siamo persi perché quell’intuizione non ha trovato il giusto riscontro prima della sua prova pratica. La finanza non può supplire all’assenza delle pubbliche istituzioni, non può e non deve sostituirsi alle entità statuali. La finanza privata non riesce a dare la risposta che ci aspettiamo. Perché fa il suo mestiere e non investe a fondo perduto. Anche perché la ricerca non sempre porta ad un risultato. Bisogna metterlo nel novero delle possibilità. Certo, in alcuni casi, uno studio può condurre ad una risposta che cambia la vita dell’umanità ma può darsi anche che si sia investito del tempo e del lavoro accademico su qualcosa che non porta a niente. Fa parte della ricerca questo rischio. E credo che sia un rischio che soltanto lo Stato può permettersi di assumere sulle spalle”.
Lo scouting di idee è uno dei perni del modello Materias. Il driver principale per la selezione delle innovazioni è rappresentato sostanzialmente da quattro parametri: novità dell’idea, livello di innovazione, applicabilità industriale e potenzialità di mercato. Ma c’è anche un altro tipo di scouting a cui il mondo della ricerca e dell’innovazione deve guardare, quello di menti giovani e brillanti da incoraggiare. Ritiene sia un’attività necessaria per evitare che vadano altrove, lontano dal Sud e dall’Italia, per raggiungere i propri obiettivi?
“Non v’è dubbio. Faccio scouting di giovani ricercatori continuamente. Alla fine non sono io a cercare loro ma loro che cercano me. Forse perché sanno di trovare una persona con mente aperta, che li può aiutare e sostenere. Ho questa fortuna. Lo scouting è parte integrante del lavoro del ricercatore. Molto spesso l’intuizione si trasforma in un progetto reale proprio dalla conversazione di più attori. Questo va spiegato anche a chi pensa che la ricerca sia un fenomeno solitario, relativo al grande pensatore che va in laboratorio da solo e scopre chissà cosa. Ciò appartiene ad una visione romantica ed anacronistica della ricerca. Quella vera, quella attuale, si basa invece su team di menti, ognuno con una sua specificità, che mettendo insieme le esperienze e la natura delle diverse professionalità fa nascere quelle idee straordinarie ed innovative, di cui poi tutti noi usufruiamo. Se utilizziamo quotidianamente tecnologie come lo smartphone, piuttosto che il forno a microonde o il telecomando dell’auto, lo si deve sempre ad un’intuizione iniziale che poi si è trasformata in prototipo e quindi in prodotto. La ricerca è molto più pratica di quanto il pubblico non addetto ai lavori possa pensare”.
Professoressa Colao, prima ha accennato all’importanza del team, della squadra, un concetto che peraltro trova piena applicazione nel suo ambito, in campo medico, con la presenza di équipe multidisciplinari che ogni giorno consentono alla medicina e alla scienza di salvare vite umane e fare passi in avanti sul terreno della qualità della vita. Ma far rete appare sempre più una necessità anche nelle prime fasi della ricerca. Cosa pensa dell’Ecosistema dell’Innovazione che ha permesso a realtà come Materias di entrare in contatto con eccellenti strutture, sia di ricerca pubblica che privata, nazionali e internazionali, creando non soltanto valore in termini di networking ma fornendo in questo modo un contributo decisivo allo sviluppo di importanti tecnologie?
“Il mondo della ricerca presenta diversi aspetti che possono scoraggiare l’inventore nel procedere ad una messa in opera della propria idea. Per tantissimo tempo, ad esempio, c’è stata questa impostazione folle, secondo cui lo studio dei fenomeni, l’intuizione scientifica, le scoperte non si sarebbero dovute mischiare con l’economia e con il denaro. Oppure c’è stato, e c’è tuttora, il timore che qualcuno possa appropriarsi della tua idea, soffiandotela. Ci sono tanti pirati nel nostro lavoro, come più o meno, nel lavoro di tutti. Però la ricerca scientifica serve anche a far sì che la pubblicazione che si fa, e l’originalità di quella pubblicazione, resti a chi l’ha pubblicata. Il punto nodale quindi qual è? È quello di avere una giusta attenzione, quando si ha un’idea innovativa, nell’andare a scegliere i partner con cui divulgare quell’iniziativa. Perché è inevitabile che ciò accada. Se la tieni solo per te, quell’idea, a che serve? Il punto fondamentale è avere invece una rete di soggetti a vario titolo coinvolti, come sta facendo per l’appunto Materias, per arrivare a condividere idee e principi da cui poter partire per raggiungere il mercato. Perché è facile dire ‘ho avuto un’idea’. Il problema non è tanto e non è soltanto l’idea, che è certamente frutto di un lavoro intellettuale molto delicato, ma la messa in opera di quell’idea, cioè come rendere l’idea qualcosa di concreto. E quest’aspetto non è mica qualcosa di banale. È una vicenda complessa, che vuole tanti percorsi, tanto lavoro. Alla fin fine credo che sia giusto e opportuno avere un partenariato che consenta di fare un salto di qualità. Un ecosistema in cui le diverse entità – la scienza, la finanza, l’industria – parlino la stessa lingua per trovare la giusta collocazione di un’idea sul mercato”
Sono diversi gli strumenti e le strategie che è possibile attuare per valorizzare i risultati della ricerca. Ad esempio, sarebbe opportuno incrementare i bonus e gli incentivi per favorire la brevettazione e la creazione di nuove startup e spin-off?
“Certo. È questa una via di mezzo tra il finanziamento immediato di un prototipo da immettere sul mercato e l’abbandono completo di quella linea di ricerca. Credo che startup e spin-off rappresentino gli strumenti giusti, che potrebbero consentire di fare qualche prova in più prima di scartare l’idea. Mi sembra una strada assolutamente percorribile. Devo anche dire che c’è stato un po’ di movimento in regione Campania sulle startup ultimamente. Continuerei quindi a lavorare in questo settore e ad investire. Magari non guardando soltanto a ricerche velleitarie e avveniristiche, come il famoso vaccino per il cancro, che è un qualcosa che non ha nessun senso reale per un ricercatore che si occupi della materia. Ma volgendo lo sguardo a qualcosa di più concreto, ad un vaccino, ad esempio, per determinati tipi di cancro. Questo sì. Perché no? Un lavoro orientato alla risoluzione di una specifica patologia va sostenuto ed incoraggiato. Mi sembra una cosa più che valida, più che giusta”.
Il modello del Fraunhofer-Gesellschaft è unanimemente riconosciuto come un’eccellenza nel campo della ricerca su scala internazionale. La distribuzione degli Istituti sul territorio tedesco è realizzata in maniera da collocare i nodi operativi in prossimità dei più prestigiosi centri universitari presenti nei vari land. La vicinanza ad un hub universitario, oltre a costituire un insostituibile canale attraverso il quale si accede alle fonti della conoscenza scientifica, è dettata dall’opportunità di poter entrare in contatto con giovani studenti, laureati o dottorandi di talento da coinvolgere sin dai primissimi anni di frequentazione accademica in progetti di ricerca applicata. La policy dell’organizzazione Fraunhofer prevede la presenza dei giovani ricercatori presso la struttura non come un punto di arrivo ma come un momento di transizione e passaggio tra l’università e il mondo dell’industria. La struttura operativa agisce dunque intenzionalmente come una piattaforma di passaggio e transito per i ricercatori, che già dai primi mesi d’ingresso presso l’organizzazione sono indirizzati verso uno sbocco lavorativo.
Professoressa Colao, che ne pensa del Fraunhofer- Gesellschaft? L’Italia cosa deve fare per avvicinarsi il più possibile a questo modello? La valorizzazione del capitale umano, specie di quello relativo alle nuove generazioni, è ancora una chimera nel nostro Paese. Non crede?
“Tutte le iniziative di scouting di menti, e di giovani menti, vanno bene. Facciamo ancora troppo poco. L’Italia appare come un Paese non meritocratico e questo è un grave vulnus. Perdiamo le migliori risorse perché non riusciamo a dare loro un segnale di inversione della rotta, della tendenza. Così l’Italia s’impoverisce. Ogni anno formiamo cervelli e poi perdiamo quella preparazione, quel valore aggiunto, regalandolo a nazioni concorrenti. Sarebbe il caso di rispolverare intuizioni operative felici, come abbiamo fatto qualche tempo fa. Ricordo ad esempio che il Miur bandì dei concorsi, 7/8 anni or sono, per selezionare giovani ricercatori di rilievo nazionale. Ciò ci permise di reclutare giovani talenti con stanziamenti dedicati, che andavano oltre l’FFO (il Fondo di Finanziamento Ordinario). Con una Commissione nazionale e il coinvolgimento di candidati di tutte le discipline, da quelle ingegneristiche e tecniche a quelle dell’ambiente geologico, medico e della ricerca di base, fino alle scienze umane. Furono assunti dei giovani ricercatori in tutta Italia. Ecco, io andrei in quella direzione. Investirei una parte dei fondi nazionali e comunitari, ogni anno, soltanto sui giovani. E questa è una cosa che spetta fare allo Stato. Diffiderei dal lasciare i finanziamenti per la ricerca nelle mani della sola industria. Perché se il ricercatore ha un’idea che si discosta dall’area d’interesse dell’imprenditore sarà costretto a rinunciarvi. Gli investimenti in ricerca si potranno fare soltanto se dietro c’è lo Stato. Ciò non significa che l’industriale non possa essere un mecenate, l’industriale può essere un grandissimo mecenate ma resterà sempre il dubbio che se si va in una linea opposta alla sua possa bloccare poi il ricercatore".
Basta lavorare sui giovani in età universitaria o bisogna iniziare anche un po’ prima?
“È proprio questo il punto. C’è poi un altro aspetto che è il vero vulnus in tutta la nostra formazione. La popolazione italiana dal punto di vista scientifico è ignorante, perché non riceve alcuna istruzione nella materia dall’epoca scolastica. L’insegnamento di scienze è contemplato dall’ordinamento ma così com’è non serve a nulla, non insegna il ragionamento del metodo scientifico, si limita a quello che già si sa. In realtà, ciò che servirebbe ai noi italiani per avere dei cervelli da destinare alla ricerca è insegnare ai ragazzi come porsi delle domande in ambito scientifico, come disegnare un modello attraverso cui dare una risposta ad un quesito tuttora inevaso. Il fatto che questo non si insegni nei vari gradi d’istruzione dà la stura ai No Vax, ai cosiddetti Negazionisti, a tutti quei fenomeni che raggruppano persone le quali pensano che leggere due righe su qualsiasi social basti a dire ‘io ho capito e questa cosa non la faccio perché è un imbroglio dello Stato’ ".
Cosa serve o cosa manca per uscire da questo equivoco?
“Mancano dei punti basilari nel curriculum delle persone. A scuola purtroppo non insegnano aspetti fondamentali che riguardano la materia scientifica, ossia che i dati si possono leggere in tanti modi diversi, che occorre andare all’origine del dato, che il dato ha una statistica e che se il metodo statistico è erratosi finirà, giocoforza, per addivenire ad una conclusione sbagliata. Sono tutte nozioni che si dovrebbero insegnare a scuola. Così come si dovrebbe insegnare a scuola l’educazione alla salute. Cosa fa bene e cosa no. Cosa c’è da sapere. Con la cattedra Unesco stiamo portando avanti, ad esempio, un progetto sulla salute degli adolescenti e ci stiamo rendendo conto che manca proprio l’Abc. Se non le si insegna a scuola certe cose come ci si può aspettare che uno possa crescere con la giusta consapevolezza. E questo è anche il motivo per cui falsamente si può pensare che in certi meccanismi entrano sempre le stesse persone. Nell’università e nei grandi organismi. Ma tale suggestione la si deve anche al fatto che chi è fuori da questo sistema non ha neanche nessuno che glielo insegna. Allora o sei proprio un cervello fuori dalla norma, fuori dalla media, e ci arrivi da solo. E per fortuna esistono ragazzi così, io stessa ho il piacere di conoscerne alcuni, perché anche tra i miei collaboratori vi sono giovani che provengono da mondi completamente diversi dalla medicina e dalla ricerca e che hanno fatto un percorso autonomo e sono arrivati a me. O rientri, dicevo, in questa categoria, oppure rischi di essere tagliato fuori dai processi. Ci sono persone e-gregie, nel senso letterario del termine, fuori dal gregge, ma - con un metodo di insegnamento diverso a scuola - probabilmente ne avremmo avuti molti di più. La verità è che noi che siamo nell’università intercettiamo i ragazzi molto tardi per dar loro un percorso formativo. Io non sono una statalista, ho sempre avuto simpatia per il mondo del privato, ma è innegabile che oggi vi sia una quota parte di tutti questi ragionamenti che dovrebbe essere in capo allo Stato. Perché è l’unico organismo che non ha interessi partigiani. L’industria deve arrivare dopo. Cioè, formati i grandi ricercatori poi ci può essere una competizione industriale per chi ingaggerà il cervello migliore e lo pagherà di più. Ma questo deve avvenire molto dopo”.
Dunque il ricercatore resta centrale ed è vero il valore aggiunto di tutto il processo?
“Ovvio ma il ricercatore è già la figura successiva, quella di chi ha potuto fare una scelta e affrontare un percorso di formazione solido e qualificato. Noi dovremmo arrivare un po’ prima a selezionare i giovani. Se vogliamo fare una cosa come la sta facendo la Germania ma migliorata, perché loro la stanno facendo soprattutto con l’apporto dei privati, noi la potremmo fare con il contributo determinante del settore pubblico. Da Stato. Dovremmo agire sui ragazzi già dagli ultimi anni di liceo”.
Lo Stato, dal canto suo, ha provato ad indirizzare i più giovani, attraverso le riforme dell’istruzione pubblica che si sono susseguite, verso il mondo dell’impresa e della ricerca. Si pensi, ad esempio, all’alternanza scuola-lavoro. È, secondo lei, la strada giusta?
“Nient’affatto. Non è una vera staffetta scuola-lavoro. È stata interpretata dai ragazzi come un momento di ricreazione, non come un momento di formazione. Queste cose vanno costruite da molto prima, questo tipo di ragionamento e di consapevolezza va gestito in anticipo nella vita dei giovani. Bisogna mandare nei laboratori soltanto quei ragazzi che hanno già dimostrato un amore per le scienze, è inutile che ci mandi tutti. Altrimenti non dobbiamo sorprenderci che poi diventi una gran ricreazione. Con i ragazzi che a tutto pensano fuorché ad ascoltare i suggerimenti su quali potrebbero essere i mezzi per il loro futuro. Secondo me, ragionamenti su vasta scala non si possono fare così, calati dall’alto”.
Nel 2012, la rivista statunitense Forbes ha coniato l’espressione game changer per riferirsi ad una figura che riesce a cambiare le regole del gioco, a pensare fuori dagli schemi, sfidare i limiti innovativi delle aziende e, così facendo, a creare nuove opportunità di business. Secondo lei, un modello del genere può servire ad avvicinare i giovani allaricerca e a rilanciare il rapporto fra conoscenza ed impresa?
“Credo che utilizzare la tecnica della competizione per andare più avanti sia un’ottima idea, mettere insieme persone che provengono da settori molto diversi apre proprio a questa prospettiva. Può capitare cheuna molecola nata in un ambito specifico poi si riveli interessante se applicata in campi diversi. E quasi sempre tale consapevolezza nasce dal fatto che in una riunione è venuto fuori qualcuno che ha proposto di provare ad utilizzarla in un altro modo. E magari i più non c’avevano pensato. Perché la base di preparazione non ha consentito di vedere quei risultati. Insomma, qualsiasi cosa possa aumentare le possibilità di utilizzodi intuizioni scientifiche va incoraggiata e il gioco, la sfida, va in questa direzione ed è un ottimo metodo”.
Sono moltissime, oggigiorno, le startup che falliscono. Il tasso di sopravvivenza dipende sicuramente da molti fattori, non ultimo quello legato all’ecosistema che le ospita, al punto che qualcuno ne paragona la nascita e lo sviluppo a quello di una pianta in una foresta pluviale (Horowitt e Hwang, 2012). Sebbene la teoria evolutiva dell’impresa sostenga che i meccanismi di selezione siano un fenomeno necessario (Aldrich, 1999) e che il fallimento delle nuove imprese sia un evento fisiologico (Watson et al., 1998; Zacharakis et al., 1999), il termine “fallire”, spesso, porta con sé un’accezione piuttosto negativa, incorporando il presupposto che colui che esercita un’attività imprenditoriale e per qualsivoglia motivo non vede concretizzarsi i risultati auspicati venga bannato come “fallito”. Nel mondo delle startup, tuttavia, il concetto di fallimento non deve essere visto con un’accezione esclusivamente negativa, sarebbe opportuno apprezzarne piuttosto gli aspetti costruttivi, di crescita dell’imprenditore e dell’ecosistema in generale. La chiusura di una società può far comprendere all’imprenditore errori nella definizione della struttura organizzativa, approcci al mercato da definire con più accuratezza e anche una gestione della cassa più oculata. Un soggetto che ha già sbagliato alcuni aspetti difficilmente persevererà nell’errore.
Professoressa Colao, crede che vada riconosciuto anche ai nostri ricercatori, come ai nostri startupper, il diritto di sbagliare?
“La ricerca è fatta anche di insuccessi, non sempre uno studio approda ad un risultato positivo e di successo. Ma anche l’insuccesso va divulgato, perché permette ad altri ricercatori di non perder tempo sulla stessa linea. Se quel percorso non è stato favorevole nasce l’esigenza di informare tutti. Può essere un monito. Un modo per dire ‘non fate così perché non andiamo da nessuna parte’. Capisco che l’opinione pubblica possa non comprenderlo ma anche l’insuccesso può essere un’informazione utile per chi fa ricerca. Talvolta, infatti, a fallire non è l’idea ma il procedimento, il metodo”
Nell’immaginario collettivo, può capitare che il lavoro di chi fa ricerca non venga apprezzato appieno. C’è il rischio che si rompa o s’incrini il patto di fiducia tra le persone e lo scienziato?
“Io dico sempre che se non ci fosse stata la ricerca, se non ci fosse stato Carlo Erba, noi ancora staremmo lì a staccare la corteccia del salice e a metterla in infusione sperando che ci passi il mal di testa. È lui ad aver estratto l’acido acetilsalicilico dal salice, ad averlo reso compressa e ad averlo chiamato aspirina dal nome di Sant’Aspreno, il santo protettore dei disturbi della testa. Così abbiamo avuto l’aspirina. La ricerca è fatta sempre di passaggi. L’idea che lo scienziato sia una persona fuori dal mondo, che sta dentro ad un laboratorio a fare strani miscugli da cui escono prodotti miracolosi è una ricostruzione iconografica che non ha niente a che vedere con ciò che fa il ricercatore oggi. Il ricercatore è una persona curiosa, che non si ferma davanti alle convenzioni, ma che si pone delle domande. Ha studiato per mettere a punto dei modelli in grado di rispondere scientificamente a quelle domande. E cercherà con tutto se stesso di addivenire ad una conclusione che lo soddisfi appieno. Se così non fosse, ricomincerà daccapo, fin quando non avrà trovato la soluzione che secondo i suoi criteri e la sua preparazione è la più plausibile alle condizioni date. Le persone devono aver fiducia nella scienza, perché è così che è progredito il mondo”.
Un’ultima domanda. Sulla pandemia da Covid-19. Oramai è chiaro a tutti che bisogna conviverci con questo virus e la ricerca sta facendo sforzi enormi per fornire alle popolazioni strumenti di sorveglianza sanitaria in grado di circoscrivere la diffusione dell’epidemia. Si può fare di più? La strada sinora percorsa è quella giusta?
“Il tracciamento del virus resta la cosa più importante per evitare la nascita di nuovi focolai endemici. Qualunque innovazione ci permetta di testare grandi comunità in tempi rapidi va sostenuta ed incoraggiata, perché è esattamente ciò che dobbiamo fare. Alla fine,bisogna ammettere che questa epidemia, dal punto di vista della ricerca,sta consentendo alla scienza di dare prova diuna straordinaria capacità nello sviluppare soluzioni tecnologicamente avanzate. La metodologia utilizzata in questo momento di crisi enorme servirà in altre situazioni di disagio. L’esperienza serve sempre a chi resterà, che studiando, vedrà cosa si è fatto e farà un altro pezzetto da aggiungere al know how esistente. L’umiltà del ricercatore risiede proprio nell’imparare da tutti enel non farsi abbattere dai risultati negativi. Perché se si è studiato bene il fenomeno e si sa quello che si sta cercando prima o poi la soluzione arriva”.










